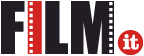La solitudine dei numeri primi
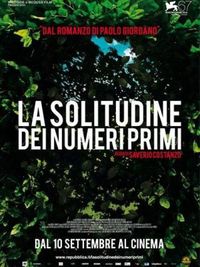
1984, 1991, 1998, 2007. Lungo questi anni le vite di Mattia e Alice scorrono parallele senza mai riuscire a congiungersi. Due infanzie difficili, compromesse da un avvenimento terribile che segnerà le fragili esistenze dei protagonisti fino alla maturità. Tra gli amici, in famiglia, sul lavoro, Mattia e Alice, portano dentro e fuori di loro i segni del passato. La consapevolezza di essere diversi dagli altri non fa che accrescere le barriere che li separano dal mondo fino a portarli ad un isolamento inevitabile ma consapevole. L'idea del film nasce dal libro La solitudine dei numeri primi di Paolo Giordano, vincitore del premio Strega 2008

“La solitudine dei numeri primi” è arrivata in Laguna, preceduta dalle attese di chi aveva apprezzato il
best seller del giovane Paolo Giordano e di chi riponeva speranze nel
lavoro molto interessante di Saverio Costanzo.
Le cose non sono però andate evidentemente per il verso giusto perché
il film purtroppo ha deluso e a tratti addirittura infastidito. Al
centro dell'intreccio drammatico, Alice e Mattia, le cui vite sono state
brutalmente dirottate nell'infanzia. In modo complementare i due sono
stati menomati, lei fisicamente, lui psicologicamente, ma nella loro
solitudine si sono incontrati. La storia di per sé molto cupa, nel
riadattamento stravolge l'ordine degli eventi procedendo avanti e
indietro tra i diversi piani temporali e svelando i rispettivi drammi
poco a poco. E fin qui tutto bene.
A non funzionare però sono i registri narrativi e l'indecisione da parte
del regista di imboccare una via definita pur esponendosi
pericolosamente. Se nei primi minuti il film sembra avviarsi con
sicurezza negli spazi del thriller, improvvisamente sembra preferire
l'horror, per poi ingranare la retromarcia verso il dramma borghese,
senza disdegnare la fantascienza. L'uso di una colonna sonora eccessiva
sfiora in certi momenti il crimine e respinge lo spettatore chiudendosi
nell'anaffettività dei personaggi, nel loro disagio tradotto in maniera
schematica in un linguaggio cinematografico che sceglie l'artificio per
rappresentare il dolore, e nel tentativo di scartare il rischio drammone
scivola nell'irrealtà quasi grottesca.
Il risultato è indigesto e il lavoro impressionante che gli attori Alba Rohrwacher e Luca Marinelli hanno fatto sui loro corpi svanisce nella sperimentazione presuntuosa o
confusa (beneficio del dubbio) che punta all'autorialità sprecando
materiale umano e narrativo. Ma perchè?