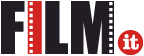NOTIZIE
Hong Kong e il cinema americano
Hong Kong e il cinema americano

25.01.2001 - Autore: Luca Persiani
L\'industria di Hong Kong, insieme al cinema italiano di genere degli anni \'60 e \'70, è quella che più ha influenzato l\'establishment del cinema che ora domina il mercato mondiale, quello americano. Ma chi sono gli autori che hanno lasciato il segno negli occhi e nello stile di personalità come Martin Scorsese, John Carpenter, Sam Raimi e Quentin Tarantino?
E\' doveroso citare per primo il decano del wuxiapian (letteralmente film di cavalieri erranti, il genere che tratta le imprese di guerrieri di arti marziali), King Hu. L\'autore pechinese, dopo aver realizzato durante gli anni \'60 e \'70 alcuni dei maggiori incassi di Hong Kong e Sudest asiatico, incrocia per primo il wuxiapian coi temi storico-fantastici della narrativa cinese (scelta che sta trovando nuova vita e nuove platee con \"La Tigre e il Dragone\" di Ang Lee). Realizza epiche di ampio respiro e innalza le arti marziali in una dimensione mistico-filosofica. Uno degli eredi diretti di questo genere è il vietnamita Tsui Hark, che dopo aver studiato cinema in America si getta in una furiosa produzione hongkongese, rivitalizzando negli anni \'80 il wuxiapian fantasy con \"Zu: Warrior of the magic mountain\" (\'83). Questa pellicola è il punto di riferimento diretto di \"Grosso Guaio a Chinatown\" (\'86), di John Carpenter, il film che per primo ha tentato, a livello popolare, di fondere gli stilemi dell\'action americano con il cinema fantastico e di arti marziali cinese. Il protagonista del film di Carpenter è Kurt Russel, emblema ironico ma concreto di un certo tipo di eroe americano molto fisico e \"pesante\", intorno al quale si scatena una danza di azione e di personaggi meticolosamente costruiti sulle figure mitologiche del fantastico cinese. Quello che ne viene fuori è probabilmente il primo film di kung fu realizzato in America, un\'idea che Carpenter accarezza sin dal 1973, anno in cui vede \"Cinque dita di morte\", di Wang Yu.
Tornando a Tsui Hark, questo regista è un po\' l\'emblema della versatilità del cinema popolare cinese: frequenta quasi tutti i generi, esplorandoli con il suo stile veloce e travolgente, appoggiato da un uso spregiudicato della narrazione e degli effetti speciali, il cui utilizzo, spesso forzatamente poveristico, ma sempre geniale e sensato, gli procura la fama di \"Spielberg d\'Oriente. Negli anni \'90 tenta, insieme con altri suoi colleghi, la strada degli Stati Uniti, dirigendo lì alcuni piacevoli action con Jean-Claude Van Damme. Notissima è la carriera americana di un quasi coetaneo di Tsui Hark, l\'\"action-man\" John Woo. Anche lui frequenta in passato diversi generi e, a dargli inizialmente il successo in patria, sono alcune commedie e l\'opera cantonese. Lo stile barocco di Woo, basato su una sorta di \"epica del ritmo\", cioè un\'attenzione estrema alla coreografia degli spazi e della violenza, e su una forte capacità di integrare quest\'elemento con stilemi melodrammatici, ha molto influenzato registi come Raimi, Scorsese, Tarantino. Sam Raimi esordisce con l\'horror \"La Casa\" che, anche se non si può dire direttamente influenzato da Woo, in realtà è molto vicino allo stile del maestro di Hong Kong appena descritto, essendo un horror violentissimo e sostenutissimo dove le serrate invenzioni visive e spaziali costruiscono e sostengono il film molto più della esile sceneggiatura. Raimi, per sua ammissione grandissimo fan di Woo, sta dietro l\'esordio del regista hongkongese in America, avendo prodotto \"Senza Tregua\", l\'action con Van Damme non completamente riconosciuto da Woo come suo a causa di un rimaneggiamento del montaggio originale. Altro grande frequentatore dell\'action movie contemporaneo è Ringo Lam, il cui stile violento, realistico e duro ritroviamo nella trilogia \"on fire\": \"Prison on Fire\", \"City on Fire\" e \"School on Fire\". Anche lui si concede una parentesi americana per poi tornare in patria con lo splendido \"Full Alert\", intenso noir dai ritmi friedkiniani. Debitore profondissimo dell\'opera di Lam è il Quentin Tarantino de \"Le Iene\", che ricalca lo schema narrativo, il look dei personaggi e la cattiveria della messa in scena proprio da \"City on fire\", di cui Tarantino si dichiara grande fan, e di cui respinge ogni accusa di plagio che periodicamente gli viene mossa. Uscendo dal particolare delle singole opere e autori, ciò che più in generale il cinema di Hong Kong ha portato a quello americano (e in particolare all\'action), oltre all\'utilizzo straordinariamente forte e ironico della violenza, è la libertà dell\'inverosimile. I registi orientali non hanno paura di raccontare storie - dal melodramma alla fantascienza - che richiedono una certa credibilità per essere seguite dallo spettatore ormai molto smaliziato, costruendole però, se necessario, su elementi narrativi, visivi e ritmici al limite del fantastico. Inoltre spostano così la \"sospensione dell\'incredulità\" (cioè lo sforzo che l\'autore deve fare per rendere accettabile il mondo che ha creato e quindi farvi così entrare lo spettatore) verso livelli completamente sconosciuti alle pratiche \"iperrealistiche\" del cinema americano. Queste scelte che affascinano così fortemente l\'industria e gli autori hollywoodiani tanto da puntare, con successo, su una nuova, originale sintesi di poetica realistica americana e astrattismo cinese in un film come \"Matrix\", che vive appunto meravigliosamente in questa sfera \"anfibia\", il cui primo sperimentatore è stato John Carpenter. Come non vedere poi nella funambolica, frammentata, rocambolesca e melodrammatica narrazione delle avventure del paramedico Nicholas Cage in \"Al di là della vita\" di Martin Scorsese, un forte atto d\'amore alle fantasie urbane più dure e scatenate di Wong Kar-Wai, Kirk Wong o Tsui Hark?