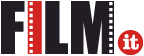NOTIZIE
Le metafore politiche di Alexander
Il film di Oliver Stone ha una duplice ambizione: quella di rivisitare il mondo antico attraverso il mito dell'eroe macedone e allo stesso tempo quella di trasformare l'appassionante vicenda storica in una metafora per il mondo attuale.

12.04.2007 - Autore: Luca Muscarà
L' Alexander di Stone ha una duplice ambizione: quella di rivisitare il mondo antico attraverso il mito dell'eroe macedone e allo stesso tempo quella di trasformare l'appassionante vicenda storica in una metafora per il mondo attuale. Tuttavia nonostante il fascino indubbio del kolossal entrambi questi ambiziosi obbiettivi possono dirsi raggiunti solo in parte. Certamente il film di Stone ha successo nel tracciare attraverso la psicologia di Alexander la profonda moralità e insieme la violenza dei rapporti interpersonali del mondo antico. Nel rappresentare le dinamiche fondamentali che legano Alessandro alla madre Olimpiade, al padre Filippo, all'amico Efestione, così come al cavallo Bucefalo, ai suoi generali e alle sue mogli, emergono una forza ed una purezza lirica che contrastano con la debolezza, la mediocrità e il pregiudizio che dominano i rapporti umani dell'Occidente attuale, e che sono troppo spesso riflessi anche nel cinema. Per quanto interpretato da un attore che non sempre pare all'altezza del proprio personaggio - Alexander, come gli uomini e le donne che lo circondano, sanno affrontare le vicende della propria vita con l'onestà e l'intensità di sentimenti degli antichi eroi del mondo classico, che sono la negazione della diffusa mediocrità contemporanea. La loro consapevolezza morale non è mai arroganza verso gli dei, ma non per questo rinuncia a quello spirito prometeico che abbatte i tiranni, e certamente quello di Stone è un felice tentativo di ritrovare nel mondo antico un paradigma intimista dello spirito sul quale rifondare attraverso i rapporti umani la coscienza occidentale.
La lettura dei caratteri che distinguono Occidente e Oriente nel mondo antico è quella stessa dei Persiani di Eschilo e se la grandezza di Alessandro è proprio quella di riuscire ad unificare anche attraverso la sua assenza di pregiudizi popoli prima divisi, il film riesce nuovamente ad essere all'altezza della storia, in una metafora in cui il nazionalismo macedone e greco ridicolizzano la persistenza di analoghi pregiudizi contemporanei, mostrando quanta poca strada sia stata compiuta intellettualmente da quel tempo. E se le atmosfere e i costumi, così come la geografia del mondo antico sono ugualmente rappresentati con grande efficacia, la debole esplicitazione dell'importanza di Aristotele nel formare la consapevolezza politica del suo giovane discepolo Alessandro è forse la lacuna più grave del film. E non perché manchino i riferimenti al filosofo, ma essi si limitano principalmente agli aspetti della condotta personale, mentre nel pensiero del grande filosofo trascendevano nella dimensione della responsabilità politica degli individui che coabitano nella stessa polis.
E nonostante l'azzeccata battuta di Alessandro che rimprovera ai suoi generali di "disprezzare le civiltà più antiche della loro", questa assenza della polis come espressione della responsabilità politica degli individui - passaggio fondamentale sul quale la democrazia moderna ritroverebbe le proprie fondamenta in quella antica - finisce con l'indebolire l'ambizione del film di essere metafora anche della guerra e delle difficoltà della globalizzazione attuali. E' vero che la modernità della lettura che Stone compie di Alessandro sta proprio nel presentarlo come coraggioso eroe nei rapporti umani prima ancora che per le sue memorabili conquiste: le sue rapide vittorie dal Nilo all'India sono infatti quelle di un primo tra pari, ed egli non appare mai sopra le righe, ma semmai un po' sotto. Tuttavia quel nesso logico che permetterebbe di fondare su quella qualità dei rapporti umani, tanto ben evidenziata da Stone, la vera forza della polis greca che proprio con Alessandro giunge a superare le rivalità tra poleis per assurgere ad un unico grande impero che darà poi vita alla civiltà ellenistica, quel nesso logico viene a mancare. Se questo collegamento tra le dinamiche interpersonali dei protagonisti e la polis fosse stato rappresentato, la potenza dell'impero di Alessandro sarebbe risultata più comprensibile proprio nel suo essere fondata su una rete di poleis collegate tra loro. Questo aspetto è invece trascurato e l'esercito di Alessandro appare come una nomade macchina da guerra lanciata verso Oriente, ma senza apparire tuttavia in grado di mantenere i collegamenti al proprio interno. E se il film riesce a ritrovare nel mondo antico quella purezza necessaria a rifondare la politica dei rapporti interpersonali a tutto campo, la possibilità che esso possa divenire anche metafora politica per la condizione della democrazia in un mondo attuale ormai tristemente privo di eroi e spesso di passioni risulta notevolmente indebolita.
E tuttavia se, come scriverà Tolomeo, il fallimento di Alessandro fu un successo ben più grande di tutti i maggiori successi di quanti lo avevano preceduto, così il fallimento del film di Stone nel rappresentare la dimensione collettiva della polis è comunque certamente un successo superiore nel suo tentativo di rappresentare la dimensione etica e dunque politica dei rapporti interpersonali rispetto a qualsiasi precedente tentativo.