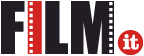NOTIZIE
Un'anima divisa in due
Un'anima divisa in due

06.07.2001 - Autore: Alessandra Taddei
Il 7 luglio di cento anni fa nasceva Vittorio De Sica, istrionico protagonista di una schiera infinita di commedie allitaliana, autore di capolavori indiscussi come Ladri di biciclette e Miracolo a Milano. Difficile scegliere fra divertimento ed impegno civile, fra il divo dedito al cinema leggero e lautore di opere neorealiste fra le più importanti e note. De Sica probabilmente preferirebbe essere ricordato come autore impegnato, se non altro perché il cinema che dirigeva era fatto spesso di progetti che gli toccava inseguire con una certa caparbietà, corteggiando produttori e mendicando finanziamenti. E con quanto orgoglio riferiva dellapprovazione incondizionata di tanti intellettuali alle sue opere del dopoguerra, labbraccio di René Clair dopo la prima parigina di Ladri di biciclette, la commozione di Chaplin di fronte ad Umberto D. Daltro canto, De Sica ha sempre tributato una considerazione limitata alle proprie prove dattore: mai una chiosa sulla sua grande bravura, sulla fama conquistata facilmente con Gli uomini, che mascalzoni, Il signor Max, Grandi magazzini, fra schermaglie amorose e sogni piccolo borghesi di pronta realizzazione. Le sue prime regie non si allontanano gran che dallatmosfera rosea dei film di Camerini che lo hanno lanciato, ma da Teresa venerdì a Sciuscià corre un abisso: nel mezzo ci sono la fine della guerra, lincontro con lo sceneggiatore Cesare Zavattini, la volontà di riprendere le difficoltà reali delle persone che camminano per strada. Il pubblico reagisce con costernazione, perché nessuno ha voglia di rivedere i propri drammi sullo schermo. Sciuscià, Ladri di biciclette, Miracolo a Milano e Umberto D, con il loro carico di sofferenze e speranze deluse, sono insuccessi al botteghino e, per potersi permettere altre regie, De Sica torna a proporsi in film altrui, sempre sorridente, ora brizzolato ma ancora fatuo, interpretando una folta schiera di avvocati, nobiluomini, marescialli, icona del neorealismo rosa come lo era stato del cinema dei telefoni bianchi. Continua a dirigere, ma per Stazione Termini gli tocca inchinarsi al produttore americano Selznick che gli impone, come era solito fare, la moglie Jennifer Jones. Poi cè Sophia Loren, cè Shirley MacLaine, ci sono Mastroianni e Sordi. Il pedinamento zavattiniano della gente comune è ormai lontano anni luce; gli stanno ancora a cuore i temi sociali, ma la magia del dopoguerra si è stemperata in trovate di maniera. De Sica lo sa, e ne soffre, maledicendo le imposizioni produttive, ma lamore del pubblico in fondo gli basta e del resto non mancano le occasioni per sfoderare grandi doti interpretative, come quando Rossellini lo dirige nel Generale Della Rovere. Può aver scontentato molti con il suo trasformismo ma, prima o dopo, ha soddisfatto ogni tipologia di spettatore e a cento anni dalla sua nascita, a ventisette dalla sua morte, la sua presenza permea, ancora vitale, il cinema italiano.