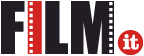A tanti il cinema di Woody Allen, più che i film, non piace: troppo intellettualismo, battute fredde, scontate, dicono. Alcuni, per sminuirlo, considerano il newyorchese un autore prevalentemente comico, se non addirittura farsesco.
Io mi annovero invece fra i sinceri estimatori e ritengo che egli sia uno dei più grandi autori della storia della decima musa. “Midnight in Paris” non è forse un capolavoro, ma certamente rappresenta uno dei suoi film più interessanti. Partiamo dalla sequenza iniziale, che ha fatto gridare i detrattori allo scandalo: Woody si è messo d’accordo con la “pro loco” di Parigi e ha fatto delle foto cartolina dei boulevard, della Senna, della Torre Eiffel e così via. No, io non credo proprio a tali interpretazioni.
L’introduzione in realtà ci trasferisce direttamente in un luogo-non luogo magico, favolistico, diverso dalla quotidianità appunto newyorchese. Ci viene posta di fronte agli occhi la Parigi di sempre, ed in particolare, quella sognata, agognata degli anni trenta: dove tutto è possibile, dove il tempo può restringersi, dilatarsi, ed in cui il “viaggio nel tempo” è del tutto plausibile, perché prodotto dai sentimenti più profondi, dalle passioni più vere, da una agostiniana “distensione dell’anima”.
L’autore infatti, che descrive una serie di viaggi-happening, come all’interno di una fessura spazio-temporale, nella Parigi del primo dopoguerra, in presenza degli interpreti artistici più famosi, con un intermezzo nella belle epoque, si avvale di tale espediente narrativo per svolgere un discorso sul tempo e sulla possibilità per l’arte di far vivere contemporaneamente, in sincronicità, più vite. La realtà delle nostre esistenze individuali risulta povera, scarna rispetto alla legittima ambizione di realizzare a pieno la nostra personalità, di accrescere il nostro sapere attraverso l’esperienza di forme diverse di espressione, che ci consentano di sollevarci al disopra e al di là anche del senso comune.
Il protagonista, un consueto “alter ego” di Allen, assiste, mentre effettua le sue scappatelle nel tempo, allo sfiorire del suo rapporto amoroso con una banale fanciulla, tratteggiata con le caratteristiche dell’americanità sguaiata (con padre rigorosamente neo-con etc.). Anche le relazioni amorose, che portiamo avanti nel corso delle nostre giornate fra mille incomprensioni e compromessi , se non animate dalla passione, stemperano e sviliscono il sacro fuoco interiore che invece riconosciamo nell’opera dei grandi: Dalì; Bunuel; Fitzgerald etc. Pertanto l’alter ego, l’ottimo Owen Wilson ha occasione di intrecciare con soddisfazione un affair con il tenero, romantico personaggio, interpretato da Marion Cotillard. L’arte, sembra suggerirci il regista, appaga la nostra anima, essa sola può elevarla in una dimensione estetica appropriata ed unica, perché assoluta e al di fuori del tempo.
L’analisi di Allen però non nega la presenza di un punto di vista storico. Allen infatti, soprattutto in questo film intende radicarsi in una civiltà di ambito precipuamente “europeo”, contrapposta alla nazionalità “americana” dell’autore, già rivendicata in opere del genere ad esempio di Manhattan. La civilizzazione occidentale nasce nel Vecchio Continente e gli Stati Uniti, anche se degni continuatori, hanno bisogno di riaccendere il rapporto con il passato per non dimenticare la propria identità. Allen quindi ripercorre e rifonda i caratteri originali della cultura occidentale, proprio in quanto americano, e quindi depositario, come colonizzatore a nome delle diverse patrie, della vera essenza dell’occidente. Però l’ambizione, nemmeno troppo nascosta, che nutriva ai tempi di Manhattan, che era quella di delineare una sorta di sostituzione nella primazia culturale da parte della colonia americana nei riguardi dell’Europa, viene abbandonata, in una sorta di progressiva e non senile delusione del grande regista per la Patria statunitense.
Probabilmente considerazioni di tipo personale, biografiche, e più generali, anche politiche, giocano il loro ruolo. Pertanto il rifarsi alla temperie di un ben determinato periodo, la Parigi del passato, è determinato da precise necessità narrative. Questo inoltre consente la realizzazione di una narrazione elegante e densa di situazioni divertenti, sorretta da una vena felice, leggera, sospesa tra il nonsense ed il tipico umorismo alleniano: fatto di osservazioni apparentemente minute, ma che tendono a spiazzare le convinzioni dello spettatore, a farlo entrare in conflitto con i suoi luoghi comuni ad aprire discorsi inattesi e nuovi orizzonti di conoscenza.

NOTIZIE
L'umorismo alleniano
Una narrazione elegante e densa di situazioni divertenti, sorretta da una vena felice, leggera, sospesa tra il nonsense ed il suo tipico humor intellettuale.

31.12.2011 - Autore: Francesco Spinazzola