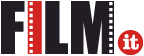Ad ogni nomination non
concretizzata – anche fosse la rappresentante di un componimento non
particolarmente eccezionale del Maestro romano – l’amarezza generale, non solo
della comunità cine-musicale internazionale, ma anche quella del grande
pubblico sempre in sintonia con l’enfasi musicale del musicista, confermava la
sensazione di un’occasione mancata, di un torto perpetrato incautamente ai
danni di una personalità da tempo meritoria, reclamante in prima persona il
riconoscimento accademico nell’establishment hollywoodiano.
E di sfide Morricone ne ha
ingaggiate continuamente. Dapprima, durante gli studi al conservatorio di Santa
Cecilia, per puro mestiere di vivere, dovendo rifugiarsi “clandestinamente” nel
mondo dell’arrangiamento leggero per sbancare il lunario. Poi, diplomatosi in
composizione, con la sua stessa prospettiva professionale: il desiderio
endemico di imporsi nel panorama classico contemporaneo e la necessità concreta
di cedere alle sirene cinematografiche, ben più redditizie del podio da
palcoscenico seppur non meno stimolanti – e anzi più facilitanti – l’innata
operosità sperimentale, l’irrefrenabile facilità all’avanguardismo. Una sfida –
quella tra musica assoluta e applicata – che con il tempo si fa compresso
interno. L’eccellenza raggiunta dall’autore nella disciplina che gli si è
imposta come principale miete collaborazioni degne di matrimoni celebrati in
paradiso: Leone, Pasolini, Petri, Bertolucci, i Taviani.
La parabola non accenna
a calare in prossimità della stagione dei generi italiani, perché alla base c’è
ancora un compromesso: pur di garantire una dignità sonora al ricco vivaio
dell’exploitation nazionale Morricone è disposto – e in più di
un’occasione vi si adopera – ad affiliarsi a prodotti di basso profilo, quando
non di basso livello. Il lounge e l’easy-listening, d’altronde,
offrono possibilità non indifferenti all’estremizzazione del timbro vocale,
all’uso strumentistico del verso gutturale. Fino all’apertura internazionale,
sancita dal sequel de L’Esorcista, diretto da Boorman. E sotto l’opera dei nomi
stranieri che seguiranno (da Malick a Joffé, da De Palma ad Almodóvar, da
Beatty a Stone fino a Nichols) il laboratorio morriconiano non cambia,
intensificando piuttosto quella tensione compositiva tra palcoscenico e musica
di commento che arriva ad approcci estremi, disinvolte scritture attraversate
da una propensione armonica modernissima. Un viaggio nello spazio, in Mission
to Mars, diventa scenario per una partitura agli antipodi del linguaggio
fantascientifico; la metafora horror di un licantropo ribelle intrappolato
nell’ipocrisia cittadina, richiama nella partitura di Wolf un romanticismo
atonale.
L’Oscar alla carriera di cui sarà
insignito il 25 Febbraio a Los Angeles, “per i magnifici e sfaccettati
contributi all’arte della musica da film”, lo colloca al fianco di Alex North –
il primo musicista specializzato meritorio di un simile premio (anch’egli
innovatore spesso sottovalutato) e scatenerà letture diversificate:
riparatorio, per il tempo perduto e l’evidente difficoltà futura di premiare un
suo score ora che il musicista ha interrotto le collaborazioni americane;
ritardatario, dovuto, addirittura risarcente (nel 1987, candidato per Mission,
gli fu eclatantemente soffiato dal revival jazz curato da Herbie Hancock per
Round Midnight e ancora prima la nomination per C’era una volta in America non
arrivò causa défaillance della produzione, che dimenticò di presentarlo tra i
possibili candidati).

NOTIZIE
L'Onorato Morricone
Dopo cinque nomination alla statuetta d'oro, l'Academy ha finalmente deciso di tributare l'Honorary Award a Ennio Morricone

12.04.2007 - Autore: Giuliano Tomassacci