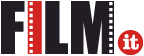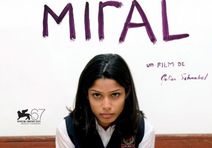Miral
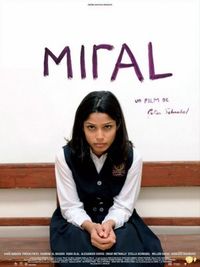
Gerusalemme, 1948. Mentre sta andando al lavoro, Hind, una giovane donna palestinese incontra un gruppo di bambini vittime di un attacco israeliano e decide di prendersene cura. Così nacque l'istituto Dar Al Tifel. 30 anni dopo, la piccola Miral di 7 anni, dopo il suicidio di sua madre, viene affidata da suo padre all'Istituto. Gli anni passano. Miral ha ora 17 anni e si trova davanti al momento delle grandi scelte: impegnarsi a tutti i costi nella causa della difesa del suo popolo o seguire l'insegnamento di Hind per la quale l'unica soluzione è l'isitruzione?

Julian Schnabel è arrivato al Lido insieme alla compagna Rula Jebreal che
per lui ha riadattato il suo romanzo autobiografico, “La strada dei
fiori di Miral”, una staffetta rosa che si allunga nel tempo e si
allaccia al conflitto mediorientale dalla genesi dello Stato d'Israele
fino agli Accordi di Oslo del 1993.
A stabilire il tracciato è la storia di Miral (Yolanda El Karam da piccola, Freida Pinto da grande), una bambina che cresce a Gerusalemme Est. Ha il nome di un
fiore che nasce per le strade e la sua storia è il germoglio di altre
storie: quelle di due donne in particolare, la sua insegnante Hind,
fondatrice di un orfanotrofio, e la madre Nadia, vittima di violenze
ripetute, che si riflettono nella sua formazione. A queste trame si
sommano le voci di chiunque abbia esercitato un'influenza su di lei, e
di chi infine ha una storia simile alla sua perché Miral rappresenta la
generazione allevata nel pieno dell'Occupazione e del conflitto che solo
grazie all'aiuto di chi ha coltivato un sogno di pace attraverso
l'amore, l'istruzione e la speranza, è riuscita a scampare ad un futuro
violento e pieno d'odio.
Il film è il frutto di una coproduzione internazionalissima che
coinvolge Italia, Francia, India e Israele e già nei credits è un invito
al dialogo. Il legame tra la sceneggiatrice arabo-israeliana e il
regista ebreo-americano rende poi questo lavoro particolarmente
personale. A cominciare dalla sceneggiatura che tradisce qualche
incertezza e soffre uno sguardo a tratti parziale e manicheo, ma
riflette suo malgrado certe semplificazioni e leggerezze che distinguono
i ricordi. A farne le spese in questo caso sono soprattutto gli uomini
che sbiadiscono in una descrizione tutta bianca o tutta nera, o ancor
più facilmente spariscono. Anche la struttura sbilanciata a svantaggio
della storia principale che entra nel vivo a un'ora dall'inizio rende il
film un po' zoppicante e lo spettatore orfano di un reale punto di
riferimento.
Schnabel ancora una volta attinge alla propria sensibilità di pittore e
nel tratto emozionale di alcune pennellate registiche conferma la
capacità di scavalcare i confini e fondere intuizioni poetiche, immagini
e suoni. Il disagio della violenza consumata su una donna si esprime ad
esempio nel dettaglio di una macchina da presa che per la vergogna di
un gesto troppo sudicio e oltraggioso indugia, si sfuoca, diventa sorda e
muta e con grazia feroce commuove e ferisce. La corrente fluisce però a
singhiozzo perché la bellezza dell'immagine rischia di congelarsi a
fronte delle lacune della storia disordinata e, così facendo, di non
aggiungere molto alla discussione se non un generico appello alla pace
che non sempre riesce a lasciarsi alle spalle il Personale per
estendersi all'Universale.
Non mancano comunque le emozioni e la fascinazione per il linguaggio
sospeso del cinema di Schnabel che si assume sempre il rischio della
sfida. E questo piace.